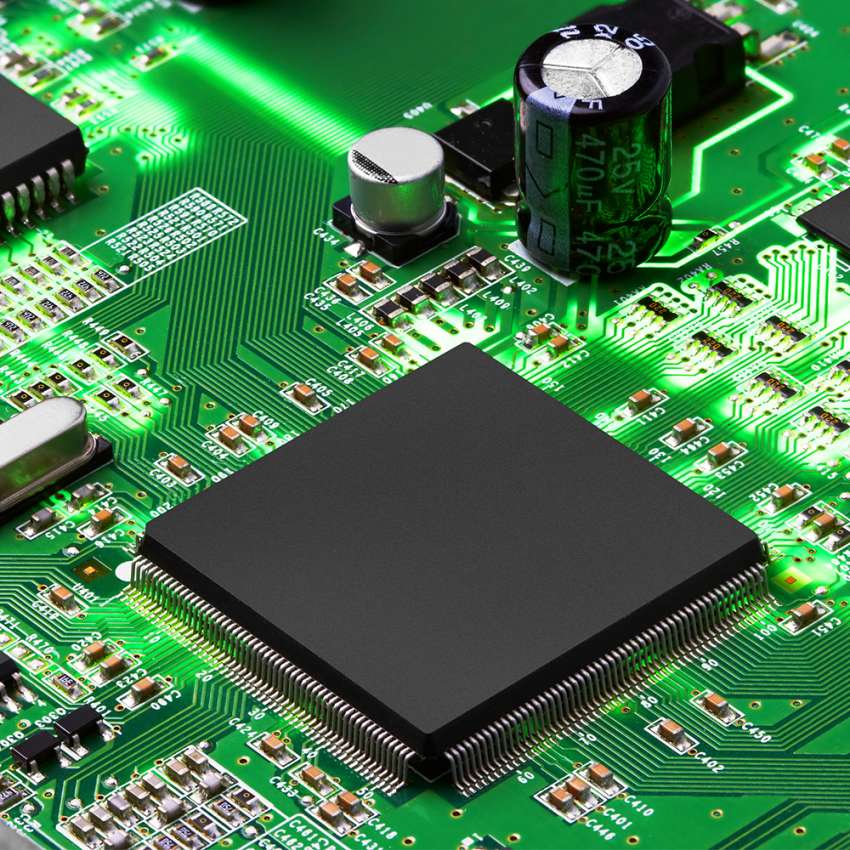Oggi le guerre non si combattono più per il petrolio, ma per le tecnologie e i materiali preziosi come i semiconduttori. Sebbene non si tratti di un conflitto armato, è in effetti in corso una vera e propria guerra economica – soprattutto tra USA e Cina (ma che non risparmia neppure l’Europa) – combattuta a suon di provvedimenti: veti agli investimenti diretti dall’estero, blocco delle esportazioni, divieti di utilizzo delle tecnologie nazionali in prodotti esteri.
I semiconduttori sono utilizzati oggigiorno in una vasta gamma di prodotti. Prevalentemente sono impiegati in computer e smartphone, ma sono anche fabbricati per usi industriali, prodotti di consumo e nel settore automotive. A quest’ultimo riguardo, nei giorni scorsi Stellantis ha lanciato un grido d’allarme affermando che le difficoltà di approvvigionamento di semiconduttori sui mercati mondiali avrà un serio impatto sulla propria produzione di autoveicoli nel secondo trimestre. Analoghi problemi, peraltro, incontrano Volkswagen e Ford che hanno dovuto diminuire significativamente la produzione, a fronte di una crescita della domanda, sopportando gravissime perdite.
Il mercato dei semiconduttori negli ultimi anni si è andato allargando a dismisura e l’offerta non è stata in grado di tenere il passo della domanda. Tra l’altro, le politiche adottate dai governi per ridurre le emissioni passano per una forte elettrificazione dei consumi (inclusa la mobilità) e contribuiscono a rendere il mercato ancora più teso.
Di qui lo sforzo dei principali paesi di conquistare (o mantenere) il controllo sul mercato, sia mediante acquisizioni all’estero da parte di aziende domestiche, sia aumentando la produzione nazionale. La dipendenza dall’estero può, infatti, rivelarsi un handicap come ha appreso, negli ultimi tempi, a proprie spese la Cina. Nel conflitto in atto per la supremazia nella tecnologia 5G, Trump ha infatti inferto un gravissimo colpo alla Huawei, impedendole non solo di acquistare i semiconduttori statunitensi, ma anche i microchip prodotti all’estero con tecnologie o software americani.
Queste misure di tipo indiretto sono particolarmente insidiose perché si estendono anche ad aziende costituite all’estero che non hanno legami col governo americano e non operano negli Usa. Più di recente, il Commerce Department degli Stati Uniti ha inserito nella black list di imprese che non possono acquistare tecnologia statunitense il produttore cinese Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), sostenendo che i prodotti di quest’ultima vengono poi utilizzati nell’industria bellica cinese.
Per evitare questi problemi, la Cina in questi anni ha cercato di attuare una politica acquisitiva aggressiva che però è finita inevitabilmente per incontrare la resistenza degli enti preposti al controllo degli investimenti diretti dall’estero. Negli USA, per esempio, durante la presidenza Trump, il Committee on Foreign Investments in the US (CFIUS) ha bloccato l’acquisizione da parte di fondi o società cinesi di due importanti società di semiconduttori (Lattice Semiconductor Corp. e Qualcomm).
E il fenomeno non ha risparmiato neppure l’Italia: proprio nelle scorse settimane la presidenza del Consiglio ha esercitato il golden power, impedendo alla società cinese Shenzen Invenland Holdings l’acquisto del 70% della Lpe (una media impresa che produce semiconduttori con una tecnologia sofisticata che permette di realizzare le connessioni tra i vari dispositivi di un chip).
Date le difficoltà a espandersi all’estero, da qualche anno Pechino sta spingendo soprattutto per un forte sviluppo della produzione nazionale in modo da raggiungere l’autosufficienza nella produzione di chip, prefiggendosi l’obiettivo di soddisfare il 40% del consumo nazionale entro il 2020 e il 70% entro il 2025 (in realtà lo scorso anno aveva raggiunto solo il 17%). A tal fine ha creato un fondo per investire nel settore, ha accordato forti agevolazioni fiscali e sta promuovendo un vivace mercato del M&A volto a consolidare il settore (nel 2020 nel mercato domestico ci sono state ben 47 operazioni relative a semiconduttori per un controvalore di 14,4 miliardi di dollari, a fronte di sole nove operazioni all’estero per un controvalore di 2,6 miliardi di dollari).
Lo stesso, con modalità ovviamente diverse, accade negli USA e in Europa. Nei giorni scorsi, per esempio, si è formata una coalizione di primari produttori e utilizzatori di chip americani (Semiconductors in America Coalition) che sta facendo forti pressioni sul Congresso affinché, nell’ambito del piano Biden per le infrastrutture, vengano destinati 50 miliardi di dollari al settore per favorire la ricerca e la produzione nazionale.
E l’Europa? La Commissione ha annunciato un piano per diminuire la dipendenza dalle forniture estere per 34 prodotti ritenuti strategici e invertire la tendenza al declino nella produzione di semiconduttori. A tal riguardo il Commissario Breton ha senza mezzi termini affermato che l’Ue è stata troppo ingenua e aperta nel fare affidamento sulle forniture di chip da Taiwan, Cina, Corea del Sud.
Altro che teoria dei vantaggi comparati. La parola d’ordine, dovunque, è “reshoring”. Costi quel che costi. E i costi non sono da sottovalutare. In Cina gli sprechi non si contano più e non tutti gli sforzi vanno a buon fine: uno dei principali conglomerati pubblici, per esempio, ha dichiarato di essere a rischio di default sulle emissioni di obbligazioni per 2,5 miliardi di dollari. Per ora, in Cina come in Occidente si pensa solo a costruire una produzione interna ampiamente sussidiata. Ma prima o poi ci si renderà conto che questo decoupling costa caro, non solo in termini economici, ma anche di sviluppo industriale.