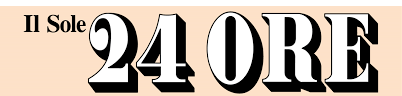Ieri è giunto in aula alla Camera dei Deputati il decreto-legge sulla cybersicurezza, che interviene anche in materia di golden power. Negli ultimi anni, i poteri speciali attribuiti al governo in relazione agli investimenti nei settori strategici sono stati modificati varie volte. Se le esigenze di tutela della sicurezza nazionale sono comprensibili ed evidenti, esse però rischiano di entrare in conflitto con l’attrazione degli investimenti esteri.
L’irrigidimento della normativa si inserisce in una tendenza, a livello mondiale, ad ampliare il novero dei settori strategici, aumentare i controlli, dilatare i poteri dello Stato. Per esempio, tra il 2008 e il 2019, a livello globale, per ogni provvedimento favorevole al commercio internazionale ne sono stati adottati 2,7 di natura restrittiva. Nel caso della libera circolazione dei capitali, è difficile avere dati, perché spesso chi vuole bloccare un operatore estero non ha bisogno di atti formali: bastano allusioni, prese di posizione o l’avvio di procedimenti complessi e lunghi. Negli Stati Uniti, per esempio, solo 5 operazioni sono state bloccate in modo esplicito, ma quelle “volontariamente” ritirate sono molte di più. Tra le cause di questo fenomeno, ci sono probabilmente le aggressive strategie di acquisizioni, soprattutto nei settori avanzati tecnologicamente, da parte di imprese cinesi. La guerra tecnologico-commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina si sta estendendo ad altri paesi.
All’interno dell’Ue, la libertà di movimento dei capitali (nei rapporti infra-europei) dovrebbe essere la regola. Eppure, la Corte di giustizia è dovuta intervenire spesso e volentieri per sanzionare chi faceva un uso disinvolto (e troppo discrezionale) delle normative sulle golden shares. L’attuale disciplina italiana sul golden power è nata nel 2012 proprio per superare l’ennesima procedura di infrazione per l’eccessiva indeterminatezza dei criteri per l’esercizio delle prerogative statali. La normativa nasce neutrale (cioè si applica indistintamente a italiani e stranieri, in ragione del settore di appartenenza, non della nazionalità). Tuttavia, la stratificazione di modifiche successive rischia di causarne una mutazione genetica. Progressivamente è stato esteso l’ambito di applicazione e i confini sono meno netti. Sempre più, poi, è marcata a regolare gli investimenti esteri (sottendendo a volte anche quali). Oltre tutto, c’è la sensazione che i vari aggiornamenti siano più il frutto di contingenze geopolitiche (la norma sul 5G fu rapidamente inserita nel decreto Brexit poco dopo la firma degli accordi sulla Via della seta) che di una meditata riforma sul grado di apertura desiderato del nostro sistema.
Questa disciplina rappresenta una lama a doppio taglio. Da un lato, è un’opportunità per attirare gli investimenti se dà certezze al mercato: il governo cioè definisce asset e settori “strategici”, procedure e tempi brevi, criteri chiari e rimedi giurisdizionali efficaci. Dall’altro lato, è un rischio se il perimetro dei poteri speciali è troppo vago, se si alimentano timori sulla eccessiva discrezionalità o sul rispetto della rule of law. Per esempio, la nostra normativa si estende agli asset “ad alta intensità tecnologica”: si tratta evidentemente di una categoria tanto ampia da poter includere virtualmente ogni impresa tecnologica. Anche l’allungamento dei tempi per il processo autorizzativo, finora molto rapidi, può divenire un ostacolo. In qualche caso, potrebbe effettivamente essere necessario svolgere adeguati approfondimenti, ma in generale si rischia di mettere a repentaglio l’operazione per le difficoltà di mantenere aperte le linee di credito.
Insomma, occorre evitare di dare il messaggio che le imprese italiane non sono realmente contendibili, perché prima è necessario acquisire il placet del Governo. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ma ricordiamo che l’attrazione di investimenti esteri e la creazione di condizioni favorevoli alla crescita sono obiettivi non meno strategici.
Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro